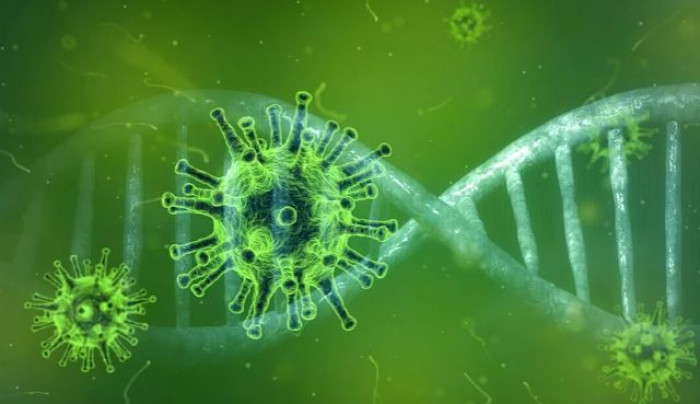
Un’analisi condotta su centinaia di migliaia di persone nel Regno Unito ha dimostrato che il numero di anticorpi nelle persone risultate positive al coronavirus tende a diminuire dopo breve tempo, particolare non da poco che contribuisce ad aggiungere ulteriori dubbi sulla capacità del nostro organismo di creare un’immunità a lungo termine in grado di proteggerci in caso di una nuova infezione.
I dati dell’analisi sono stati raccolti nell’ambito dell’iniziativa REACT-2, organizzata per testare oltre 350mila persone proprio per valutarne i livelli di anticorpi. E’ stato riscontrato che nel giro di quattro mesi il numero di soggetti che presentavano anticorpi specifici contro il coronavirus erano diminuiti del 26%.
Infatti le analisi condotte a luglio dimostravano che ogni 1.000 pazienti testati, 60 presentavano degli anticorpi specifici. Nei test condotti a settembre, sempre su 1.000 soggetti, solo 44 presentavano degli anticorpi. In questo breve periodo di tempo, dall’estate all’autunno, sembra che il numero di persone con anticorpi sia diminuito di poco più di un quarto.
Studiando più nel dettaglio i risultati ottenuti è possibile osservare che la riduzione è stata più marcata nei soggetti di età superiore ai 65 anni, rispetto a quella riscontrata nei soggetti più giovani. E’ vero però che gli anziani in genere tendono ad avere un sistema immunitario meno efficiente, quindi questo, assieme ad altri fattori, potrebbe spiegare la differenza.
I ricercatori hanno anche osservato che una maggiore diminuzione del numero degli anticorpi è stata riscontrata in soggetti che avevano contratto il virus ma senza mostrarne i sintomi, quindi i cosiddetti “asintomatici“, rispetto a pazienti che avevano a tutti gli effetti sviluppato la patologia.
Sono poi state rilevate anche delle differenze nelle varie “categorie”. Gli operatori sanitari, ad esempio, hanno dimostrato di mantenere il livello degli anticorpi abbastanza alto per più tempo rispetto alla media della popolazione.
I ricercatori hanno ipotizzato che questa differenza sia da attribuire all’ambiente di lavoro, poiché tutti gli operatori sanitari sono maggiormente esposti al virus e per più tempo rispetto al resto della popolazione, quindi questo potrebbe provocare una risposta ricorrente da parte del loro sistema immunitario.
Altri casi di coronavirus
I “quattro coronavirus” più ricorrenti nella storia dell’uomo, ben prima della diffusione dell’attuale (Sars-CoV-2), sono i responsabili del raffreddore comune e in genere provocano la manifestazione di sintomi leggeri che tendono a sparire nell’arco di una settimana.
Diversi studi condotti in passato hanno rivelato come, con il passare del tempo, il nostro sistema immunitario tenda a “dimenticarsi” di loro, consentendo quindi di sviluppare nuove infezioni. La durata della memoria del nostro organismo varia da soggetto a soggetto, ma in media è stato stimato che vada dai 6 ai 12 mesi.
Ci sono poi dei tipi di coronavirus in grado di causare malattie ben più rischiose, come la Sars e la Mers, che gli esperti sono riusciti a contenere evitando che causassero una pandemia, come nel caso del Covid-19.
Gli studi condotti finora, seppur fatti su un numero limitato di pazienti, hanno rivelato che il sistema immunitario, dopo aver incontrato i virus che causano queste malattie respiratorie, sviluppa una memoria della durata di circa 1-2 anni.
Quindi, considerando che il Covid presenta delle analogie con la Sars, i ricercatori credono che anche i tempi di protezione dell’organismo debbano essere simili.
Tuttavia stabilire con certezza quale sia la durata della memoria del sistema immunitario è molto difficile per due motivi principali. La prima, valida in quasi tutti gli ambiti della medicina, è legata al fatto che ognuno di noi rappresenta un organismo differente e di conseguenza risponde diversamente alle eventuali minacce che incontra, come virus e batteri.
La seconda invece è che le conoscenze sul sistema immunitario sono ancora molto limitate, infatti non sono note tutte le variabili che ruotano attorno alla memoria immunitaria.
Gli anticorpi, come quelli misurati nell’analisi condotta nel Regno Unito, hanno la capacità di legarsi ad alcune proteine del Coronavirus, impedendogli di legarsi alle membrane delle nostre cellule, entrarvi all’interno e sfruttarle per replicare il proprio genoma, producendo così tutte le componenti necessarie per moltiplicarsi.
Vi sono però altri meccanismi di difesa che vengono attuati dal nostro sistema immunitario, alcuni molto specifici, mentre altri sono più generali ma comunque efficaci, soprattutto nelle prime fasi dell’infezione.
Una volta debellata una minaccia, tutte le risorse, cellule e non solo, prodotte dall’organismo per difesa, vengono utilizzate per la creazione di una memoria immunitaria che però non è sempre stabile. In alcuni casi la memoria è duratura, quindi offre una difesa per lungo tempo, mentra in altri casi tende a svanire rapidamente, asciandoci indifesi contro minacce già debellate una volta.
E’ naturale che gli anticorpi contro specifici patogeni si riducano nel tempo, via via che ci si allontana dal periodo dell’infezione. Tuttavia il sistema immunitario conserva delle cellule, i linfociti T e B, che ormai hanno acquisito dei recettori, ossia delle proteine, in grado di riconoscere specificatamente un determinato patogeno.
In caso di una nuova infezione, quindi, questi linfociti vanno subito in replicazione, aumentano notevolmente in numero, e aggrediscono prontamente il bersaglio riconosciuto come “non-self” (agente patogeno, estraneo all’organismo). Non è però ancora chiaro per quanto tempo queste cellule rimangano all’interno dell’organismo.
Fino ad ora i casi riportati di pazienti che hanno contratto per la seconda volta il coronavirus sono davvero pochi, a sostegno della tesi che la memoria immunitaria in alcuni casi svanisce completamente, lasciando il soggetto non protetto da una seconda infezione.
I casi riportati sono appunto pochi e sono in corso degli studi per comprenderne le cause. Infatti, nonostante venga contratta nuovamente la malattia, i sintomi sviluppati dai pazienti sono molto più lievi, segno quindi che una minima traccia di memoria immunitaria è comunque presente.
I ricercatori che hanno portato avanti l’analisi nel Regno Unito invitano a non trarre conclusioni affrettate, poiché sono ancora molti i meccanismi da chiarire sul Covid-19. La diminuzione degli anticorpi potrebbe influenzare anche la capacità di un eventuale vaccino di proteggere dalla malattia, ma anche qui sarà necessario attendere i risultati delle sperimentazioni in corso dei vari candidati vaccini.
Infatti se da una parte è vero che i campioni sviluppati agiscono stimolando il sistema immunitario a sviluppare una risposta immunitaria simile a quella che si avrebbe contraendo il virus vero e proprio, dall’altro è vero anche che questi farmaci agiscono in modo più complesso sul sistema immunitario stesso e sulla sua capacità di creare una memoria.
Analisi di questo tipo quindi non mettono in dubbio l’efficacia di un eventuale vaccino, né la necessità di svilupparne uno e di diffonderlo il prima possibile tra la popolazione mondiale. Non è possibile escludere però che, se venisse sviluppato un vaccino efficace, sia necessario sottoporsi a richiami periodici per mantenere la risposta immunitaria.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati.
Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta,
causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.
- Zero Commissioni sui CFD
- Oltre 800 ETF a zero commissioni per i primi 3 mesi (soggetto a condizioni).
- Strumenti avanzati di analisi







